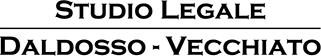Recentemente ha fatto scalpore la notizia di due artigiani ceramisti pugliesi i quali, in occasione della festa della mamma, hanno pensato di riproporre un loro prodotto, una tazza riportante la scritta “Un po’ la Franzoni la capisco”, così riferendosi evidentemente al caso di Annamaria Franzoni, madre che nel lontano 2002, come venne accertato in sede giudiziale, uccise il figlioletto di due anni, Samuele Lorenzi.
Sebbene gli artigiani siano ormai noti al pubblico per commercializzare prodotti di ceramica (e non solo) caratterizzati da frasi ed immagini umoristiche, irriverenti, ironiche, a volte persino sarcastiche o volgari, il prodotto promosso come cadeau per la celebrazione tipica del mese di maggio ha spaccato il web in due. I commentatori si sono infatti divisi tra coloro che, in nome della libertà di espressione hanno difeso la scelta dei due artigiani di promuovere un “contenuto” che potremmo definire quantomeno macabro, e quelli che si sono invece detti scioccati dalla scelta poco delicata di fare riferimento (e sfruttare quindi) per la realizzazione di una tazza ad un episodio così tragico.
Ora, ai giuristi saranno sicuramente venuti in mente i numerosi profili giuridici che emergono in relazione ad un caso come quello sopra descritto, profili che verranno di seguito brevemente passati in rassegna, con la premessa che le intenzioni dell’autore non sono quelle di contribuire alla polemica creatasi, ma di ampliare il dibattito e far sì che questo trascenda dalle reazioni spontanee (e sempre legittime) che l’episodio ha generato. In un certo senso, dunque, potrebbe parlarsi di un “caso nel caso”, in quanto in sé e per sé anche la semplice scelta di utilizzare un riferimento alla vicenda penale per finalità diciamo “commerciali” può offrire interessanti spunti al giurista.
Ebbene, escludendo a priori che possa configurarsi qualche diritto di proprietà intellettuale in capo alla Franzoni (in senso lato intendendosi il nome come “marchio”), e questo per gli evidenti profili di nullità che verrebbero in tal caso a configurarsi, occorrerà soffermarsi sulla tutela del diritto al nome garantita dall’art. 7 del Codice Civile, oltre che (indirettamente) dall’art. 8 CEDU, che introduce strumenti di tutela della vita privata di ciascun soggetto e dall’art. 14 CEDU sul principio di non discriminazione. Oltre a ciò, sovverrà al giurista il diritto all’oblio o ad essere dimenticati, il quale è inteso dalla giurisprudenza come espressione del diritto alla riservatezza (Cass. civ., Sez. III, 09/04/1998, n. 3679), cristallizzato nell’art. 17 GDPR, articolo che pure sancisce alcuni contrappesi rispetto al diritto di cancellazione del dato, tra i quali l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione, nonché la necessità di archiviazione del dato per ragioni di interesse pubblico. Tali diritti all’interno del nostro ordinamento sono peraltro ulteriormente radicati ed elevati a principi fondamentali in virtù delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, che sanciscono la protezione della persona umana nel suo complesso. Analoga tutela, come è noto, è tuttavia garantita anche al diritto di espressione e quello di satira ai sensi dell’art. 21 Cost..
Ora, in particolare con riguardo al diritto all’oblio, la giurisprudenza ha chiarito che esso “prevale sulla satira ingiustificata per il personaggio noto che non riveste un ruolo primario della vita pubblica nazionale (figura pubblica) e la cui vicenda non abbia spessore di un contributo al dibattito pubblico, come le vicende su fatti criminali, di preminente interesse politico o economico o ancora su fatti di ordine pubblico o sulla sicurezza delle persone”(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 6919/18; depositata il 20 marzo).
Ebbene, alla luce di ciò si può facilmente ipotizzare che un giudice non vedrebbe di buon occhio l’utilizzo del nome della sig.ra Franzoni nel modo che abbiamo descritto, e questo perché ella ha cessato di essere oggetto di rilevante dibattito ormai da molti anni ed in particolare dal 2018, anno in cui ha terminato di scontare la pena inflittale.
Peraltro, occorrerebbe effettuare un’approfondita analisi anche di eventuali profili diffamatori dell’episodio, in quanto sebbene la satira non debba, per sua natura, sottostare al parametro di verità previsto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, essa è comunque sottoposta agli ulteriori requisiti di continenza e pertinenza. Recente giurisprudenza ha infatti chiarito che “sussiste l’esimente del diritto di critica (art. 51 c.p.) quando il giudizio negativo collegato a specifici fatti sia veicolato in forma scherzosa e ironica e non si risolva in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o in disprezzo personale (Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza 10 gennaio 2022, n. 320).
In ogni caso però (ed è su questo che l’essere umano -ancor prima che il giurista – deve soffermarsi), a prescindere da cosa potrebbe decidere un tribunale qualora fosse investito di una controversia o di una causa penale relativa al caso di specie, occorre chiedersi quale sia il contesto adatto per un giudizio (anche se implicito) sulle vicende di una persona che ha affrontato i meccanismi della giustizia e scontato la pena inflitta (sia essa giusta o meno).
In altre parole, queste forse troppo povere, occorre chiedersi se una tazza sia il posto giusto per una sentenza.
Avv. Giulia Sofia Cucurnia